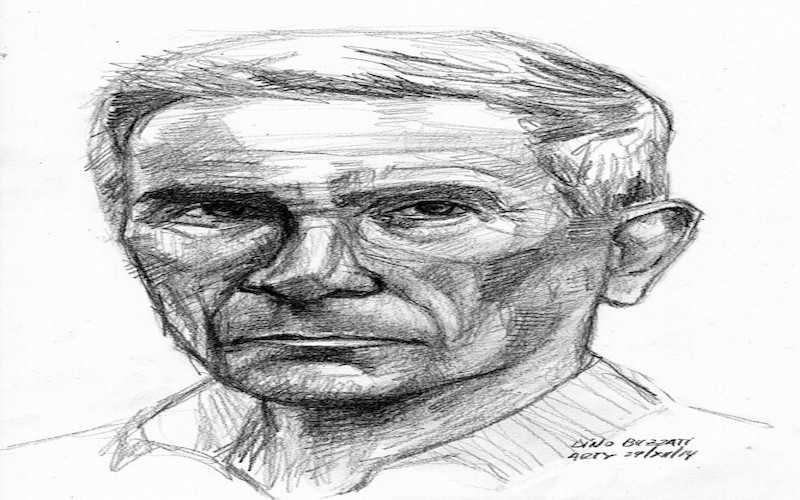
L’invocazione di Buzzati a un Dio non conosciuto
Tre anni fa avevamo parlato di Dino Buzzati in coincidenza con la tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia: si ripercorreva una mitica giornata di sport che lo scrittore e giornalista del Corriere della sera aveva narrato come pochi sarebbero stati in grado di fare. Ecco, le sue passioni, poi trasfuse in raccolte di articoli opportunamente ripubblicate da Mondadori, erano infatti la cronaca nera e le cronache sportive: quegli ambiti della pratica giornalistica praticando i quali si impara a raccontare concentrandosi sull’essenziale. Una palestra in cui ci si addestra a evocare, a dipingere con pochi tratti, la complessità delle vicende umane: ambizioni, paure, angoscia, sforzo condotto strenuamente, delusioni.
È in fondo quel materiale umano che Buzzati mise anche nei suoi moltissimi racconti (la raccolta più importante resta Il crollo della Baliverna, 1954) e ovviamente nel Deserto dei tartari (1940), il racconto delle aspirazioni del sottotenente Giovanni Drogo; il giovane sottufficiale ha tutto per essere destinato a una seria carriera militare: tradizione di famiglia, accademia frequentata con profitto, modi composti e senso del dovere; ha tutto, tranne quel nemico che dovrebbe dare senso alle aspirazioni collettive degli altri soldati e ufficiali della fortezza Bastiani. Drogo morirà senza aver combattuto un solo giorno, ma la forza della narrazione sta nell’espressione dei sentimenti, dell’attesa, delle pause. Ne derivò anche un ottimo film per la regia di Valerio Zurlini nel 1976, ma prima ancora Buzzati in persona lavorò al “trattamento” di una versione cinematografica poi mai realizzatasi: pochi mesi fa Mondadori ha mandato in libreria una nuova edizione del romanzo, con in appendice appunto gli schemi per il film e altri materiali, a cura di Lorenzo Viganò. Ma non dimenticherei che anche Jacques Brel, uno dei massimi chansonnier francesi, dedicò al protagonista del “Deserto” una bella canzone, Zangra.
Come capita molte volte in occasione degli anniversari, ci si interroga sulla fede o non fede dell’autore: nel caso di Buzzati l’esercizio critico ha coinvolto varie firme, con posizioni diverse e interessanti: lo scrittore spagnolo Javier Cercas, su La Stampa nel 2008, senza sposare la tesi di un Buzzati “credente”, sottolineava il carattere di speranza che traspare dalle opere buzzatiane, tirando in ballo un’altra questione ricorrente, cioè la vicinanza di Buzzati con l’opera di Kafka. Una tesi che alcuni sostengono, ma che non convince altri, come Cercas stesso. Cercas vede in Buzzati una speranza per una vita ulteriore e diversa (anche se non quella della fede cristiana) che invece non esiste in Kafka.
Il giornalista cattolico Vittorio Messori, invece, un anno prima su Avvenire, respingeva con decisione la tesi che esista un momento “religioso” nel Deserto dei tartari. Lo ritiene un «libro disperato». Una presa di posizione un po’ estrema, giusta nel sottolineare l’assenza della fede, anche se, più che sottolineare la disperazione, personalmente credo che la cifra del Deserto sia la malinconia. Sullo stesso quotidiano interveniva la giornalista Lucia Bellaspiga, che aveva affrontato il tema in un libro il cui titolo suona: «Dio che non esisti ti prego». Dino Buzzati, la fatica di credere (ed. Ancora, 2006) Un lavoro che va credo nella direzione giusta: si occupa infatti dell’ansia di chi, non credente, intuisce che il senso della nostra esistenza non sia tutto quantificabile nelle nostre opere e nei nostri giorni, ma porti con sé il riflesso di qualcosa o qualcuno che ci supera. Autorizzerebbero a pensarlo – scrive Bellaspiga – non il Deserto ma diversi racconti successivi.
Anni prima un altro narratore del Triveneto, Carlo Sgorlon (1930-2009), aveva affrontato l’opera del bellunese Buzzati sulle pagine della rivista storico-letteraria Nuova antologia, all’epoca diretta da Giovanni Spadolini. In un ampio articolo del 1985, ammettendo le similitudini di alcuni racconti e temi fra Buzzati e Kafka, dice giustamente che «mentre Kafka appartiene totalmente alla cultura ebraica (…) Buzzati invece è calato per intiero dentro un’antropologia cristiana, e tutta la sua opera è avvolta da un alone di pietà. Di origine cristiana è anche una certa vocazione di Buzzati alla rinunzia; la sua accettazione della solitudine cenobitica, claustrale, che caratterizza tanti personaggi dello scrittore cadorino». E ancora: «Essi fanno della rinunzia una sorta di severa divisa, o di abito monastico, e si vestono di essi, vivendo la vita non direttamente ma come di riflesso, nei suoi echi e nelle sue malinconiche risonanze».
Insomma, non siamo autorizzati a pensare la fede come compagna delle giornate di Dino Buzzati, ma troviamo in molte sue pagine una percezione che ebbe, per esempio, Albert Camus (ne avevamo parlato in un incontro zoom organizzato da Riforma con il filosofo Telmo Pievani. Camus sembra rimpiangere, in alcune pagine della Peste, la possibilità di dialogo che il credente ha con Dio, un Dio che egli stesso non riusciva a invocare. E anche Buzzati, probabilmente, non è stato credente; ma sapeva che cosa sono un uomo o una donna in preghiera; evocava lo sgomento che ci attanaglia di fronte alla natura e all’imponderabile; sapeva che ci sentiamo tutti, a volte, molto piccoli e bisognosi di trovare risposte e conforto; non praticante, tuttavia intuiva da poeta, e faceva propri, le “posture” del salmista, le sue invocazioni. A Buzzati è mancato forse qualcosa; lo scrittore non è riuscito a incontrare Dio, come Giovanni Drogo, ormai avanzato nei gradi della carriera militare, non riesce a incontrare un nemico. Noi, che da credenti leggiamo e a volte rileggiamo quelle pagine, troviamo un ulteriore richiamo a far risuonare in noi quegli appigli di dialogo con quel Dio a cui forse egli ha aspirato, invano ma sinceramente.
Immagine di Arturo Espinosa

